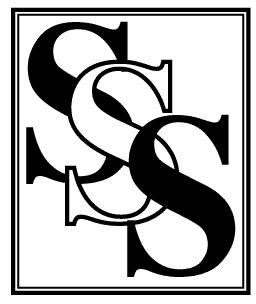di Ida Zanini
Dall’inizio di questa avventura, che risale al 1986, diversi avvenimenti sono successi: la rassegna annuale è proseguita ininterrottamente attraverso collaborazioni con enti e associazioni varie, l’iniziatore Giorgio Piombini è mancato, diverse chiese sono state chiuse, e altro ancora. Nel 1997 cominciò, e tuttora prosegue, la collaborazione col Gruppo di Studi Savena Setta Sambro di Monzuno attraverso la pubblicazione dell’opuscolo dei concerti d’organo estivi come allegato alla rivista semestrale dell’associazione. Il contributo annuale dei comuni di San Benedetto, Monzuno, delle varie parrocchie, di Emilbanca, dei privati che sostengono il progetto, è fondamentale. Nel 2018, Daniele Ravaglia, presidente del gruppo di studi Savena Setta Sambro ha proposto alla sottoscritta di curare la rassegna, inserendo nel titolo il nome della persona che aveva iniziato questo lavoro, così da quell’anno la rassegna ha assunto il titolo di Itinerari Organistici Giorgio Piombini e tuttora continua con al suo attivo, un ragguardevole numero di organi restaurati il cui elenco si trova sempre in questa pagina web.
L’idea di valorizzare gli strumenti musicali antichi presenti nell’Appennino bolognese nacque da una proposta che fu accolta e che, per una serie di volontà, propositi, pian piano prese forma la rassegna, ampliandosi negli anni, sensibilizzando le varie comunità locali e amministrazioni a rivalutare i preziosi strumenti antichi che in tante chiese erano presenti. Riporto degli stralci di un articolo che scrissi per la rivista Savena Setta Sambro n. 34 del 2008.
Da sempre in casa mia a Rioveggio eravamo a conoscenza del bellissimo organo presente nella chiesa di Montorio. Mio padre Luciano, grande appassionato di musica, da bambino era stato chierichetto e, quando non serviva all’altare, aiutava l’organista Aldino di Pian di Lama azionando a mano la leva posta dietro lo strumento, per dare aria ai mantici. Il mio primo ricordo di bambina, riferito a quest’organo, è di come fosse bello, in braccio a papà, accoccolarsi sulla sua spalla ed essere cullata da quelle armonie.
Questo corposo strumento venne ampliato nel 1885 dal Verati, organaro bolognese, con registri[1] tipicamente ottocenteschi; al suo interno conserva materiale fonico del 1500, 1600 e, per tutto il 1900, ha mantenuto la sua integrità. Fino a dopo la II guerra mondiale veniva suonato da Aldo Ruggeri (Aldino) di Pian di Lama (1869-1950), poi lentamente venne suonato sempre meno, fino ad essere completamente dimenticato.
L’organista per le celebrazioni più importanti arrivava a piedi, per la Messa delle 11.30, suonava e accompagnava il coro, che eseguiva i canti tradizionali propri del periodo liturgico e le parti fisse della Messa in Gregoriano. Al termine, clero, organista, campanari, sagrestano e chierici erano tutti invitati in canonica al pranzo preparato da Rosa, la sorella del parroco, in attesa nel pomeriggio dei Vespri, rito con cui terminava la festa. Nelle ricerche d’archivio abbiamo trovato, alla voce “Regalìa all’organista”, l’entità dei suoi compensi.
All’arciprete don Settimo Marconi (Granaglione 1867 – Montorio 1960), molto stimato dai Montoriesi, e qui parroco per ben 67 anni, si deve il merito della buona conservazione e integrità dell’organo. Come ricordava mio padre Luciano, infatti, ad Aldino che gli proponeva di togliere certi registri, perché non più ammessi in chiesa, dopo la Riforma della Musica Sacra col Motu Proprio di Pio X del 1903, don Settimo rispondeva, candidamente, di non usarli.
Era il 1986 e da tempo lo strumento non veniva più suonato; mio marito Giorgio Piombini, in occasione di una sua visita, l’aveva trovato funzionante, ma solo parzialmente. Spinto dagli insistenti e amorevoli inviti di mio padre che spesso andava ripetendo: – A Muntóri aiè un bel organ / A Montorio c’è un bell’organo. –
Giorgio rassicurò il parroco don Valentino Valentini circa la validità dello strumento e il suo possibile recupero. Il parroco si mostrò ben disponibile, per cui decisero insieme di chiedere il sopralluogo all’organaro Paolo Tollari di Fossa di Concordia (Mo), il quale dopo aver visionato lo strumento, disse che era molto prezioso e ben preservato. Con una buona ripulitura delle canne, con il ripristino della meccanica, della catenacciatura[2], con un nuovo motore e un’accordatura generale l’avrebbe rimesso in efficienza, in attesa poi di un restauro più profondo e sostanziale.
Il dott. Tollari, grande appassionato del suo lavoro e per compiacere mio marito, diede la sua disponibilità per il restauro, ma c’era un solo problema: il tempo. L’unico periodo libero era durante la chiusura estiva della sua ditta, che però significava mancanza assoluta di aiutanti. Giorgio, senza battere ciglio, offrì gratuitamente la sua manodopera e così, durante il periodo delle sue ferie, passò da Responsabile del Museo Civico Bibliografico Musicale di Bologna (ora Museo e Biblioteca Internazionale della Musica) ad Aiutante dell’Organaro e… l’avventura iniziò! Fu chiamato da Bologna, per un sopralluogo, l’Ispettore Onorario agli Organi Oscar Mischiati, che diede il parere favorevole al progetto di ripristino dello strumento.
Quell’anno trascorremmo tutto il periodo di ferie da mio padre: Giorgio ogni mattina, come un diligente operaio, si infilava una tuta da meccanico e partiva; io gli preparavo uno spuntino e lo rivedevo solo a sera quando ritornava tutto impolverato e un po’ stanco, ma molto soddisfatto, sia per come procedeva il lavoro, sia per le persone ospitali del posto, con cui aveva modo di parlare.
Con legittimo orgoglio mi parlava dei progressi compiuti giorno dopo giorno: era molto laborioso curare ogni singola canna, anche quelle schiacciate a causa del materiale tenero di cui erano fatte, pulirla, riposizionarla, accordarla. L’organaro era infaticabile e solo per la pausa pranzo uscivano dalla chiesa. Spesso don Valentino preparava un pranzo frugale in canonica. Anche i parrocchiani li invitavano: Giorgio mi raccontava del buon vino bevuto a casa di Dino Giardini, poi delle chiacchierate in casa di Giuseppe Porrini, con Sergio Bertuzzi, con l’allora sagrestano Alfonso Ventura, degli aneddoti dei Montoriesi sulla vita passata, quando la borgata era ancora ben popolata. Anch’io qualche volta, in compagnia di mio padre, andavo sul ‘luogo di lavoro’ di mio marito, ma dopo una breve sosta per illustrarci lo stato dei lavori e per una bibita fresca, riprendevano di gran lena l’opera che doveva essere terminata prima della fine di agosto. Il parroco ogni tanto si affacciava e, scherzando, raccomandava loro di non cacciare tutti i ragni, perché in fondo anche loro erano creature del Signore!
Nel volgere di un mese circa, fu completata la rimessa in funzione; la spesa sostenuta dalla parrocchia fu di circa £ 1.700.000 e praticamente consistette nell’acquisto di un elettroventilatore nuovo e per l’onorario all’organaro. Giorgio, nel frattempo, aveva contattato l’organista della basilica di San Biagio di Cento, Davide Masarati (1959-2013), che prontamente accettò l’invito a inaugurare il ritrovato strumento dell’Appennino bolognese. Insieme pensammo a un elenco di brani che mettesse in evidenza le peculiarità foniche dello strumento, e quindi furono stampati i programmi di sala. Alla fine dei lavori, l’organo appariva veramente in tutto il suo splendore.
Nel piccolo centro si era creata una grande aspettativa e tutti volevano riascoltare il suono di quello strumento muto da più di trent’anni. La sera del 31 agosto 1986, la chiesa era gremita: alla presenza delle autorità, dopo i ringraziamenti, la spiegazione dei lavori eseguiti e la preghiera, ebbe inizio il concerto d’inaugurazione. L’emozione poteva toccarsi con mano e durante il concerto a qualche anziano scappò una lacrima. Il programma prevedeva brani che andavano dal 1600 al 1800 con autori quali Benedetto Marcello, Bassani, Predieri, G.M. Martini, Berg, Kerll, Pachelbel, Gherardeschi, e Davide fu veramente bravo anche nel far sentire la diversità timbrica dei vari registri. Mio padre osservò che quella sera il M° Masarati aveva ‘spolverato’ bene l’organo e aveva fatto scappare proprio tutti i ragni!
Dopo il concerto, siccome ‘tutti i Salmi finiscono in gloria’, un po’ più rilassati e contenti per il felice esito della serata, dopo le foto ricordo, andammo a festeggiare alla trattoria Cà Benassi a Veggio di Grizzana Morandi, dove ci avevano aspettato, nonostante l’ora tarda, con una bella tavolata, rallegrata dalle rinomate tagliatelle e il buon vino. Altri due concerti ebbero luogo quell’anno a Montorio e così a seguire, ogni anno, con ulteriori strumenti recuperati in altri paesi dell’Appennino. E fu proprio con questo evento che prese vita la rassegna annuale, ideata e voluta da Giorgio Piombini, che all’inizio s’intitolava solo “Concerti d’Organo”, poi, man a mano che qualche organo storico veniva restaurato la rassegna s’ingrandì sempre di più, intitolandosi “Itinerari Organistici nell’Appennino bolognese”, poi “Itinerari Organistici nella Provincia di Bologna” e ora “Itinerari Organistici Giorgio Piombini”.
[1] File di canne con medesimo timbro.
[2] Insieme di leve, fili, bilancieri che hanno il compito di trasmettere i movimenti dei tasti ai ventilabri dei somieri.